Recensione: “Uno, Nessuno e Centomila” di Pirandello - di Teresa Vecchio
“Ora ritornando alla scoperta di quei lievi difetti,
sprofondai tutto subito, nella riflessione che dunque-possibile?- non conoscevo
bene neppure il mio stesso corpo, le cose che più intimamente m’appartenevano,
il naso, le orecchie, le mani, le gambe e tornavo a guardarmele per rifarne
l’esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ricondurmi in
breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne
sarei morto o impazzito, ove in esso
medesimo non avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene”.
Così ha inizio la vicenda di Vitangelo Moscarda, di ventotto anni e di buona famiglia:
il padre era stato banchiere, abile negli affari e uomo tutto d’un pezzo. Lui invece,
di quieto vivere e malleabile al volere e alle aspettative di tanti altri, era stato
destinato ad ereditarne solamente i soldi e l’etichetta di “usuraio”, che ancor
prima di nascere gli era stata riservata dalla maggior parte della gente. Gli
affari e la banca erano stati lasciati nelle mani di esperti soci del padre (Sebastiano
Quintorzo e Stefano Firbo), il quale “nonostante si fosse adoperato con le
buone e cattive maniere”non era riuscito a far concludere nulla al figlio, se
non il matrimonio con l’altrettanto giovane moglie Dida; senza ottenere però
alcun nipote prima della sua morte. “Non già badiamo ch’io opponessi volontà a
prendere la via per cui mio padre m’incamminava.
Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo ad ogni passo;
mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino, a girare attorno ad
ogni sassolino che incontravo, e mi meravigliavo assai che gli altri potessero
passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto
aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile anzi di un mondo in
cui avrei potuto senz’altro domiciliarmi.” E così accade: quel pomeriggio la
moglie fa notare al suo caro Gengè quei difetti del volto e del fisico di cui
lui stesso mai si era accorto. Lei lo consola che, nonostante tutto rimane un
bell’uomo, ma la stizza del momento
diviene in breve angoscia profonda di una riflessione e di un monologo (spesso
esplicitamente rivolto al lettore, totalmente coinvolto) di un uomo di fronte
all’assenza della coscienza e di una realtà propria. “La solitudine non è mai
con voi; è sempre senza di voi, e soltanto possibile con un estraneo attorno:
luogo o persona che sia che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate
così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in
un’ incertezza angosciosa e cessando
ogni affermazione di voi, cessi l’intimità stessa della vostra coscienza. Così
volevo io esser solo. Senza me.” Prosegue così sino ad arrivare alla
conclusione che quell’uno, quel Moscarda che credeva gli appartenesse in realtà
è solo un’ombra a lui estranea e sconosciuta, che vivendo non poteva conoscere
e non rappresentava a lui alcuna immagine di sé. “ io non ero più un indistinto
io che parlava e guardava gli altri, ma uno che gli altri invece guardavano
fuori di loro e che aveva un aspetto ch’io non mi conoscevo”. Un’apparizione di
sogno: ciascuno se lo poteva prendere quel corpo lì per farsene quel Moscarda
che gli pareva e piaceva. Chi era dunque colui? Nessuno. Un povero corpo senza
nome in attesa che qualcuno se lo prendesse. L’uomo per sua natura si conosce,
conosce gli altri e le cose costruendosele in qualche modo: possiamo conoscere
infatti soltanto quello a cui riusciamo a dare forma, momentaneamente; e la
realtà che uno possiede per l’altro, è quella stessa che quest’altro gli
attribuisce. Vitangelo mai aveva saputo dare una forma alla sua vita, così per
la sua natura incline a cedere, e ad abbandonarsi alla discrezione altrui
(non per debolezza, ma per noncuranza e anticipata rassegnazione ai
dispiaceri) non si conosceva affatto, non aveva per sé alcuna realtà propria,
ma malleabile come “in uno stato di continua fusione” . “ ma che altro avevo io
dentro, se non questo tormento che mi scopriva nessuno e centomila? (…) a chi
dire io? Che voleva dire io se per gli altri aveva un senso e un valore che non
potevano essere i miei; e per me così fuori dagli altri, l’assumerne uno
diventa subito l’orrore di questo vuoto e di questa solitudine?”. Così si
propone di scoprire chi è almeno per quelli che gli stanno attorno, più vicini,
i cosiddetti conoscenti, divertendosi nel “giuoco” di scomporre dispettosamente
e follemente quell’io che era per loro. Decide di sconvolgere gli affari della
banca e quindi di tutti quei soci che ne sono coinvolti, demolendo quelle tante
proiezioni che avevano fatto di lui la loro marionetta, additata da tutti come
responsabile dell’usura e di tutto quel denaro. Tutto questo a partire proprio
dall’immagine di quel caro Gengè di sua moglie che con orrore di lui, lei
baciava e abbracciava: un impenetrabile ideale del perfetto marito, un
abbandonarsi del suo corpo, fiducioso che in realtà non si desse realmente a lui
Vitangelo. Due estranei non solo l’uno per l’altra, ma ciascuno a sé stesso, in
quel corpo che l’altro si stringeva. “Non poteva ammettere lui (il suocero) che
gli levassi il genero dalle condizioni in cui se ne era stato finora, cioè da
quella comoda consistenza di marionetta che lui, da un canto e la figlia
dall’altro e dal canto loro tutti i soci della banca, gli avevano dato. (…) E
vi giuro che l’avrei lasciato lì se io per mio conto me ne fossi potuto andare
altrove con un altro corpo e un altro nome”. Per forza questo gioco gli fruttò
la pazzia e la piena coscienza di questa. Abbandonato da tutti, in attesa di
accuse per esser chiuso in manicomio, viene aiutato da un’amica della moglie,
la quale sempre aveva sospettato dell’amore di lui per lei. Lo stesso
Vitangelo, sempre rimasto indifferente a questa donna, si convince anch’egli
del sentimento che tutti pensavano lui provasse segretamente. Anna Rosa spaventata
poi dalle riflessioni che lui le confida tenta di ucciderlo, ferendolo
gravemente con una rivoltella. Accusato dal giudice del processo di violenza e
additato da tutti come adultero, si affida alle parole di Monsigor Partanna,
investendo tutto il suo denaro e i suoi beni in favore dei più poveri. In
questa più totale sconfitta trova la sua rivincita, quel rimedio che lo
guarisce, che si trova nel medesimo dolore che lo aveva angosciato. “l’essere
agisce necessariamente per forme, che sono le apparenze ch’esso si crea, e a
cui noi diamo valore di realtà. Un valore che cangia naturalmente, secondo l’essere
in quella forma e, in quell’atto, ci appare.(…) una realtà non ci f data e non
c’è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere: e non sarà mai una per tutti,
una per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile”. In questa continua
moltiplicazione l’io perde l’individualità, da uno diviene centomila e quindi
nessuno. Lo scoprirsi nessuno fa sì che egli finalmente, rifiutando qualsiasi
identità e immergendosi nuovamente in quel flusso primordiale della natura (da
cui l’uomo distaccandosi come individuo, comincia a morire, ad essere finito)
muore e rinasce ogni instante dell’eterno divenire, senza ricordi, vivo e
intero, divenendo un "tutt’uno con ogni cosa fori di sé", lasciando il vuoto
delle vane costruzioni. In totale estraniazione da una città e da un pensiero
ormai lontani. Così la vita non conclude.
Vecchio Teresa 5C

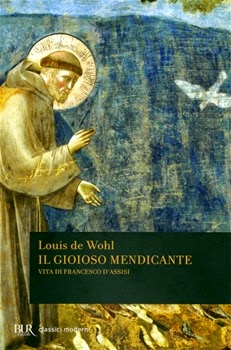


Commenti
Posta un commento